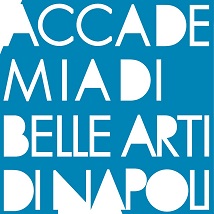L’inaugurazione della nuova Aula Magna con l’allestimento e la riesposizione dei calchi in gesso fidiaci del prezioso e raro fregio del tempio di Atena, il Partenone (447-432 a.C.), segna un traguardo importante nell’ambito della politica culturale dell’Accademia, particolarmente attenta alla tutela e valorizzazione del suo prezioso patrimonio storico-artistico, documentario e librario, i cui topos sono la Galleria, la Gipsoteca, la Biblioteca Anna Caputi, l’Archivio Storico, il Teatro Antonio Niccolini e il Giardino dell’antico chiostro. L’Aula Magna è un altro importante capitolo che entrerà a far parte della storia della nostra Istituzione grazie all’attuale progetto architettonico che appunto include l’esposizione dei calchi delle parti decorative del Partenone.
Infatti, fin dalla seconda decade del XIX secolo, l’Accademia di Belle Arti di Napoli conserva nel suo cospicuo patrimonio di gessi antichi un nucleo importantissimo riguardante la decorazione scultorea del Tempio di Atena. Il complesso plastico, tranne tre lastre del fregio, è totalmente ricavato dai marmi che Lord Elgin portò in Inghilterra da Atene – dove il Partenone, che dal V secolo a.C. dominava con la sua mole l’Acropoli, era in stato di abbandono – e furono da allora esposti nel British Museum. Esaudendo gli auspici di Antonio Canova, il quale riteneva che ogni artista dovesse conoscere questi capolavori della scultura antica, venne realizzato un calco di tutti i marmi.
Il nucleo è composto da tre tipologie plastiche: metope, fregio e sculture dal frontone est. Le quattro metope, ad altorilievo, provengono dal lato sud del tempio (il solo dove si fossero conservate) e raffigurano scene della Centauromachia; il fregio, a bassorilievo, rappresenta la Processione panatenaica ed è composto di formelle che formano una scena continua; i gruppi scultorei, quasi a tutto tondo, sono due e presentano dei e dee. Tutti i calchi – tranne tre formelle del fregio, provenienti da Atene – giunsero a Napoli nel 1820 come dono di Giorgio IV d’Inghilterra a Ferdinando I di Borbone e sono di straordinaria qualità. E tutto ciò nasceva dalla ferma volontà di Antonio Canova che intendeva arricchire l’Accademia di Belle Arti di quegli archetipi del classico per antonomasia, indispensabili alla formazione degli artisti del futuro.
Ancora oggi il Partenone è simbolo di civiltà, archetipo di equilibrio, armonia e misura, massima espressione dei valori estetici ed etici dell’umanità, in una visione illuminata che esalta l’uomo nelle sue capacità intellettive e sentimentali. È un simbolo imperituro dell’antica Grecia e della democrazia ateniese e rappresenta senz’altro uno dei più grandi monumenti culturali del mondo.
Dal loro arrivo a Napoli nel 1820, i calchi fidiaci sono stati montati e smontati più volte e alcune di queste movimentazioni vi hanno purtroppo lasciato tracce. Un primo allestimento dovette essere a Palazzo degli Studi, forse appoggiando le lastre su mensole in legno. Un secondo allestimento, probabilmente quando l’Accademia si era già trasferita nell’attuale sede, ovvero l’antico convento di San Giovanni delle Monache restaurato da Errico Alvino, ha previsto l’ancoraggio delle lastre tramite chiodi con testa a vista; i fori vennero poi stuccati dopo la rimozione. Più tardi, lastre e metope furono allestite una terza volta, in un aula dove attualmente è situato il Teatro dell’Accademia, tramite zanche al di sopra del rilievo. L’allestimento è documentato da una foto storica dei primi anni del ‘900. Il fregio fu poi allestito per la quarta volta negli anni ‘50 all’interno del Teatro costruito tra il 1952 e il 1954 secondo il progetto e la direzione dei lavori di Giuseppe Cotugno. Rimosso alla fine degli anni ’90, è stato poi restaurato dalla Scuola di Restauro dell’Accademia. Intanto era chiaro che l’attuale restyling del Teatro Antonio Niccolini, su progetto di Massimo Alvisi, non poteva più prevedere l’esposizione del fregio alla luce delle sostanziali modifiche apportate sia nella sala, sia nel palcoscenico, così come è stato restituito da pochissimo a docenti e allievi, in occasione del “Premio delle Arti” nel giugno 2010.
Per tutti coloro che sono stati coinvolti in questo nuovo progetto, la collocazione del fregio, nonché quella delle metope e delle statue fidiache, ha rappresentato una sfida impegnativa al pari dell’apertura della Gipsoteca. Il restauro, durato cinque anni e iniziato quando era direttore Alfredo Scotti, è stato diretto da Augusto Giuffredi. Contemporaneamente si è condotta un’approfondita indagine storica e iconografica volta a studiare anche una adeguata collocazione, senza la quale ogni restauro non può dirsi terminato. Per quanto l’edificio dell’Accademia sia apparentemente enorme, il valore architettonico dei grandi corridoi del primo piano e dall’ampio scalone non permettevano di pensare ad una collocazione al loro interno senza stravolgere un ambiente storicamente connotato. Per questo, la ricerca di uno spazio adeguato è stata il frutto di una discussione approfondita durata più di un anno che ha coinvolto, oltre chi scrive ed Augusto Giuffredi, anche il Soprintendente Stefano Gizzi, progettisti e allestitori come gli architetti Lucio Turchetta e Nicoletta Ricciardelli, nonché studiosi di alto profilo come i coniugi Mertens, tra i massimi esperti di arte greca, ai quali va tutto il nostro debito di gratitudine. Va sottolineato come queste ricerche siano state seguite passo passo dagli studenti che hanno a più riprese collaborato con la direzione scientifica, creando quello che è davvero un cantiere-scuola, ovvero un cantiere di conoscenza.
L’individuazione della grande sala al primo piano e della sua antisala e la decisione del Consiglio Accademico, in sintonia con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, di destinarla ad Aula Magna, ha consentito di individuare contestualmente e finalmente il luogo ideale per esaltare l’unicità della decorazione plastica fidiaca.
La felice attuale soluzione ha ovviamente tenuto conto di seri studi iconografici e storiografici. Nel Partenone la processione aveva inizio all’angolo sud-ovest della cella; i calchi riproducono la sequenza narrativa, partendo dal lato ovest. È stato svolto un lungo lavoro di analisi e studio della documentazione fotografica storica degli originali che raccoglie in un’unica sequenza le lastre presenti nei musei di diversi Stati. L’attenzione è stata rivolta, chiaramente, alla collezione presente al British Museum di Londra, poiché è dall’Inghilterra che si diffusero le copie dei marmi del Partenone e da cui provengono anche quelle conservate nell’Accademia di Napoli. In tal modo è stato possibile individuare e ordinare i calchi analizzati. Così, durante le ultime indagini sono state riconosciute tre lastre che non sono attualmente conservate al British Museum, bensì al Nuovo Museo dell’Acropoli di Atene. Il riallestimento del complesso plastico in uno spazio che ne esaltasse l’unitarietà era ideale: infatti, pur essendo il fregio situato nella parte superiore della ‘cella’ del tempio, quindi non visibile contemporaneamente ai frontoni e alle metope situati all’esterno del tempio, essi costituiscono un complesso stilisticamente unitario, dominato dalla personalità artistica di Fidia. L’individuazione dell’Aula Magna ha consentito così di creare un altro polo della Gipsoteca. Il recupero di affascinanti ambienti storici dell’Accademia e delle antiche porte, secondo un linguaggio architettonico contemporaneo, crea un’opera in sé in cui protagonista è la stratificazione e la contaminazione della storia: dalle presenze classiche alle volte della sala del secolo XVII, ai discreti elementi di arredo contemporanei.
Sono state adottati sistemi sofisticati di allestimento. Tecnicamente il fregio è sostenuto da una griglia metallica, infissa nella muratura retrostante che, oltre a sostenere le formelle, sorregge anche due fasce, in alto e in basso, di ‘isolamento visivo’ del manufatto.
L’illuminazione è contenuta nella struttura di sostegno del fregio ed è composta di due tipi: nella parte superiore, nascosti dalla fascia che corre in alto lungo il fregio, corpi illuminanti di grande potenza sono diretti verso la volta, dalla quale è riflessa verso il basso una luce ambientale; nella parte inferiore la luce scende lungo il perimetro delle pareti, con effetto wall-wash; infine, una sottile striscia luminosa di LED sottolinea la giunzione tra la struttura ed i muri. La visibilità dei percorsi è in questo modo garantita anche nel caso che la sala debba essere oscurata. Una ulteriore fonte di illuminazione è costituita dai riflettori sospesi alla struttura metallica trasversale e diretti verso il fondo della sala che consentono una gestione della luce di tipo più ‘teatrale’. Una sala versatile e polifunzionale, dunque, all’avanguardia anche dal punto di vista acustico e illuminotecnico per essere il cuore culturale e pulsante di un’istituzione come l’Accademia, proiettata verso il futuro.
Anche l’Aula Magna, quindi, come la Gipsoteca è laboratorio di conoscenza e luogo di studio, cosicchè l’esposizione delle parti decorative del Partenone non vuole essere una semplice musealizzazione, anche se rispetta standard espositivi museali che favoriscono la giusta fruizione delle opere esposte. Convinti come siamo che i saperi devono essere tràditi per essere tradìti, questo è il senso e il valore dell’Aula Magna e della Gipsoteca dell’Accademia di oggi e di domani, questo il futuro del classico: il recupero dell’antico e dell’archetipo come strumento di formazione artistica a futura memoria ed insostituibile stimolo per la creatività.
L’inaugurazione della nuova Aula Magna conclude i lavori di studio e di restauro sui gessi Fidiaci protrattisi per circa otto anni.
Il lavoro prese avvio nel 2002, grazie all’interessamento dell’allora vicedirettore prof. Alfredo Scotti che, diventato poi Direttore a sua volta, diede continuità all’intervento. La prima fase fu solo conoscitiva e fu da me condotta nell’ambito dell’insegnamento di Restauro 2. La situazione di partenza era piuttosto sconfortante, le lastre accatastate una sull’altra erano depositate nell’attuale Galleria del Giardino dell’Accademia a piano terra. La relazione prodotta servì innanzitutto a verificare il numero delle opere e a valutarne lo stato di degrado. Nell’anno accademico 2003-04 iniziò il recupero delle trentatré lastre della processione panatenaica. Come docente del corso di restauro stucchi e gessi fui nominato responsabile e direttore dei lavori realizzati dagli allievi della Scuola di Restauro, corso di Conservazione e restauro delle opere d’arte moderne e contemporanee. La supervisione e l’alta sorveglianza dell’intervento spettava alla ex Soprintendenza BAPSAE, retta dal Soprintendente Enrico Guglielmo, funzionario responsabile Dott.ssa Gemma Cautela, con la quale si è instaurato un proficuo rapporto grazie al quale è stato possibile iniziare, sviluppare e portare a termine l’intero intervento conservativo.
Su alcune lastre del fregio panatenaico, una serie di provinature consentiva di identificare la patina originale, ritrovata al di sotto di una pesante applicazione di “acqua di creta” messa in opera quando il fregio venne montato nel teatro negli anni Cinquanta. La procedura seguita per i restauri ha avuto una forte valenza didattica. Per ogni pezzo è stata redatta una scheda con i dati identificativi, soggetto, dimensioni, numeri di inventario, nonché le osservazioni inerenti le tecniche di formatura adottate grazie a rilievi grafici delle tracce lasciate dai tasselli sul calco. La scheda veniva completata producendo una mappa del degrado, nonché un progetto di massima dell’intervento. Una campagna fotografica, estesa anche al retro, completava l’indagine preliminare. Il docente di diagnostica Prof. Donato Inverso ha analizzato microprelievi delle lastre confermando quanto precedentemente riscontrato.
Tre erano gli stati conservativi dei calchi fidiaci, il più problematico era senza dubbio quello delle lastre del fregio, meno grave quello dei due gruppi scultorei, e in uno stato discreto si trovavano le quattro lastre delle metope che, essendo murate già da lungo tempo a notevole altezza, avevano subito meno danni. Sul primo gruppo è stato adottato un sistema di impacco a base di acqua distillata per rimuovere lo spesso strato di creta. L’uso dell’acqua pone un problema dovuto all’igroscopicità del gesso; per tale ragione le formulazioni impiegate comprendono l’aggiunta di sostanze addensanti che trattengono il liquido in superficie, limitandone la penetrazione. La composizione e le percentuali possono variare da caso a caso (una di queste prevede una miscela di metilcellulosa, seppiolite, glicerina ed acqua distillata; l’altra, l’aggiunta di silice micronizzata altre ancora l’uso di laponite ecc.). Va sottolineato come l’abilità e la sensibilità dell’operatore siano fattori decisivi per una buona riuscita della pulitura, anche se non sempre viene posta la dovuta attenzione a questa variabile, a favore della correttezza e scientificità del sistema applicato. Gli stessi tamponi in cotone che sono stati risolutivi per ridurre lo spessore dell’argilla, possono provocare danni se non si comprende appieno quando e come utilizzarli. Una serie di ottimi risultati si sono ottenuti ultimamente con l’utilizzo dei gel di Agar-Agar. Grazie ad una serie di incontri e confronti con colleghi restauratori che sperimentano e testano questo prodotto, ho avuto modo di adottarlo nel corso di restauro a partire dal 2008. Il lavoro di pulitura, nella maggior parte dei casi, si è rivelato migliorativo rispetto ai precedenti sistemi e consente gradualità e possibilità di controllo. Sui gessi del fregio e sulle metope non è stato applicato nessun consolidante, né altro trattamento finale in quanto superfluo. I due gruppi scultorei sono stati restaurati dal Prof. Ignazio Di Bella, docente di Restauro dei materiali lapidei.
Hanno collaborato in tutto più di settanta allievi per portare a termine questo importante cantiere-scuola che si è sviluppato parallelamente ai lavori della Gipsoteca.
Un ringraziamento particolare in primo luogo ai protagonisti di questa impresa, gli allievi del corso di restauro, al Direttore Giovanna Cassese che ha saputo col proprio lavoro dare degna collocazione alle opere, al Presidente Sergio Sciarelli e a tutto lo staff amministrativo. Collaborando con colleghi amici, come l’Arch. Lucio Turchetta docente di Allestimento spazi espositivi e con l’Arch. Renzo Cecconi, nonché con gli artigiani e trasportatori coinvolti, si è riusciti a concretizzare e portare a termine ciò che all’inizio dell’intervento sembrava solo una mera utopia.
Giovanna Cassese
curatrice
allegati
elenco delle opere esposte [scarica qui]